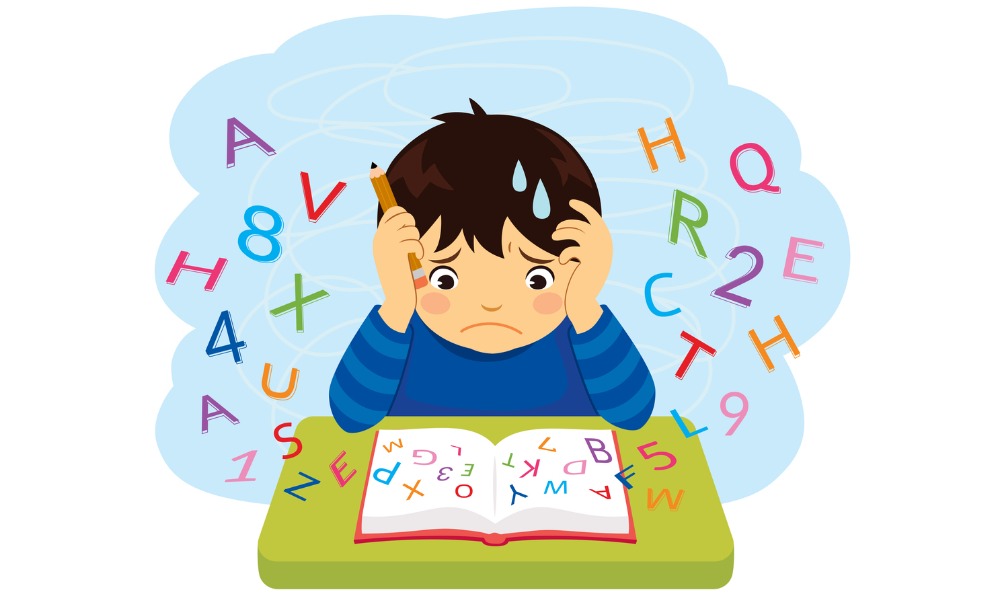
Un disturbo DSA è un disturbo specifico dell’apprendimento, dovuto ad un disturbo del neurosviluppo che comporta difficoltà isolate e circoscritte nella lettura ( dislessia) nella scrittura (disortografia e disgrafia) e/o nel calcolo (discalculia), in soggetti sche non presentano disturbi sensoriali e con sviluppo intellettivo globale nella norma.
La prevalenza dei bambini con DSA in Italia è stimata intorno al 4% con una frequenza maggiore nei maschi.
Si è passati dallo 0,9% nell’anno scolastico 2010/2011 al 5,4 % nell’anno scolastico 2020/2021. Maggiore nel nord-ovest Italia (7,9) ,minore al sud (2,85) .
I fattori di rischio e gli indicatori che permettono di sospettare la diagnosi in età prescolare sono:
a) il ritardo del linguaggio
b la familiatità
c) disturbo della coordinazione motoria
d) difficoltà di apprendere i compiti routinari
e) Aver subito anestesie nel primo anno di vita ( espone ad un aumento del rischio.)
Il disturbo viene individuato a scuola già dall’ultimo anno della scuola dell’infanzia, anche la famiglia però ed il pediatra possono porre attenzione a degli elementi suggestivi, per esempio il bambino che confonde alcuni fonemi come pane con cane, che non sa denominare rapidamente una serie d’immagini, oggetti o colori, che non sa sa quale suono corrisponde a quella lettera o viceversa potrebbe avere una dislessia o una disortografia.Il bambino che non sa ordinare per altezza e lunghezza e non sa fare distinzione tra uno/molti, vuoto/pieno e non sa quanti sono i compagni di classe potrebbe avere una discalculia.
Gli indicatori tardivi sono quelli del disagio psicologico:
a) tristezza
b) irritabilità
c) scontrosità
Oppure indicatori somatici
a) nausea
b) disturbi del sonno
c) dolori addominali
d) cefalea
che sono legati all’esperienza frustrante di confrontarsi con una sproporzionata fatica scolastica
Quindi le bandierine rosse sono:
- la presenza di un attuale o pregresso disturbo del linguaggio
- la familiarità per DSA o altri disturbi del neurosviluppo soprattutto ADHD (bambino iperattivo).
- la discrepanza delle competenze scolastiche acquisite rispetto ai compagni
- l’aumento del tempo e della fatica nel fare i compiti associato alla ridotta autonomia ( bisogno di aiuto costante)
- indizi di disagio psicologico quando si reca a scuola
- evitamento delle attivià scolastiche o evidente sofferenza nell’applicarsi sui compiti
Secondo la Legge 170 la diagnosi di DSA deve svolgersi nell’ambito del SSN da specialisti dedicati, non è stato riconosciuto nei livelli essenziali di assistenza (LEA) per cui non è previsto un sostegno economico e le famiglie devono sostenere autonomamente il costo degli interventi di recupero. E’ possibile però usufruire dell’indennità di frequenza che viene valutata dalla commisione medica dell’INPS un volta presentata la domanda formulata dal PdF.
I bambini con DSA non necessitano di percosi di apprendimento alternativi con riduzione o modifica dei contenuti didattici, ma solo le cosiddette misure compensative per es. mappe concettuali, tecnologie informatiche o altro, e misure dispensative, cioè eliminare prestazioni non necessarie ai fini della qualità dei concetti, come ad esempio leggere ad alta voce. Queste misure sono garantite per tutto il percorso di studi fino all’Università.
Quindi le metodologie e gli strumenti possono essere diversi e la scuola deve formulare un piano didattico personalizzato (PDP).
Anche i compagni del bambino con DSA possono essere coinvolti nel percorso di recupero avvlendosi dell’apprendimento cooperativo, modello ingrado di promuovere le diversità nelle condivisione valorizzzando le competenze del singolo e invitandolo a metterle a disposizione del gruppo.
Estratto da una intervista alla dott.ssa Antonella Gagliano NPI dell’Universià di Messina, pubblicata su medico e bambino del 31 0tt. 2024


Leave a Comment